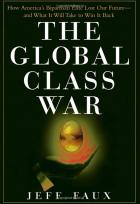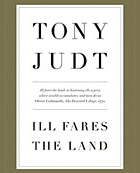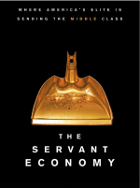Institutes |
L'Univerdtà non è per i giovani
Sottotitolo:
Domina il burocratismo, che si serve dello sfruttamento di giovani “volontari” desiderosi di studiare. Si parla poco dell’Università, considerato tema d’élite. Ma si sbaglia: in Italia, da circa quindici anni l’Università pubblica e la ricerca scientifica attraversano stagioni infelici. Non che prima fossero rose e fiori, ma il declino è aumentato partendo dalla cosiddetta “Riforma Gelmini” (2012). Ovviamente soffrono di più Università e Centri di ricerca del Sud. Al Nord, infatti, Università e istituzioni culturali, operando in una realtà più ricca, ne traggono indubbi benefici. Come finanziamenti privati della ricerca (o Master o altre iniziative d’alta formazione), nonché occasioni di lavoro per bravi laureati (banche; società finanziarie; grandi industrie). E’ naturale che i migliori giovani del Sud ne siano attratti, impoverendo così i nostri territori e abbassando il livello della classe dirigente meridionale. A fronte del malessere dell’Università pubblica c’è il successo e la prosperità delle Università telematiche, tutte private. Che, grazie al bizzarro legislatore, rilasciano un identico titolo di studio.
Per l’Università pubblica il problema principale è sempre il solito: scarse risorse finanziarie – guarda caso, ulteriormente tagliate dal Governo – ma adesso non è il solo. Vi s’accompagna la farraginosità dei finanziamenti della ricerca: procedure complicate per avere soldi tramite progetti. Le quali, in mancanza del personale tecnico-amministrativo, vengono accollate agli studiosi. Incredibili compiti burocratici distolgono i professori dai loro compiti istituzionali (ricerca e didattica in presenza). Inoltre riunioni su riunioni, non di studio ma di gestione di strutture accademiche, afflitte da inutili controlli. Insomma domina il burocratismo, che si serve dello sfruttamento di giovani “volontari” desiderosi di studiare. Sono alle prime armi ma, pieni di speranze, volentieri si lasciano sfruttare. Negli ultimi tempi sono stati abilitati, quali Professori associati o ordinari, centinaia di studiosi in ben quattro tornate annuali di “abilitazione nazionale”, mentre i posti veri sono pochissimi in quanto le singole Università, che dovrebbero “chiamarli”, non hanno soldi. Ha senso abilitare cento persone sapendo che, attraverso l’imbuto, saranno al massimo cinque o sei ad avere un posto? Si corre ai ripari allungando il tempo di validità dell’abilitazione e svuotandone il senso: un “vecchio abilitato” rischia di lasciarci le penne se, superando la frustrazione, non arricchisce titoli e produzione scientifica per il concorso vero e proprio, che è “locale”. Ed è meglio sorvolare, per carità di patria, sul prevalere così del “localismo competitivo”: fatto appunto d’una feroce concorrenza più che della tanto millantata meritocrazia. Con il Pnrr s’è fatta festa aumentando le “borse di dottorato di ricerca” nelle diverse discipline. E sono stati infatti selezionati giovani molto bravi. I quali però, conseguito il dottorato, si guardano intorno spaesati. Perché, esaurita la sbornia del Pnrr, sono stati tagliati gli “assegni post-dottorato” e ancor più i “posti di ricercatore”. Che fine faranno tutti questi bravi dottori di ricerca, soprattutto del Sud, cui viene impedito di continuare a studiare col miraggio d’una meta scientificamente qualificata? Purtroppo sappiamo che fine faranno: andranno ad allargare l’area della disoccupazione giovanile intellettuale o ripiegheranno su qualche lavoro mal pagato, lontano dai loro interessi di studio. Chissà se la Ministra Bernini è a conoscenza della gravità di questi problemi e pensa di risolverli con la dovuta razionalità. (Editoriale del Corriere del Mezzogiorno, 2 febbraio 2025) Mario Rusciano
Professore Emerito di Diritto del lavoro, Università di Napoli Federico II. |