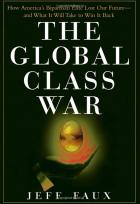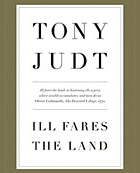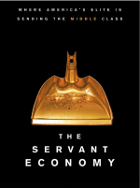Torno a pubblicare su questo blog. Le ragioni? Un senso di generale scoramento nell’osservare gli sviluppi della realtà in cui viviamo. Della scuola non voglio neppure parlare, tanta è l’amarezza nel constatarne il declino intrinseco, Su un piano ben più critico e decisivo per le nostre stesse vite e per quelle dei nostri figli e nipoti è l’attuale situazione globale, “senza imperi”, ma con molti “imperatori”, simile a quelle che, in taluni periodi della storia romana (alla morte di Nerone, ad esempio) vengono definite “gli anni dell’anarchia”, preda di dinamiche evolutive impredittibili, per spiegare le quali mi pare oggi vano ogni commento. L’ondivago (?) presidente Trump ne è la tragica incarnazione. Ecco qui di seguito una modesta riflessione nata da una del mie periodiche riletture dei poemi omerici, in questo caso l’Iliade, libro IX, vv. 502 e ss., al riparo dai rumori molesti prodotti da un’informazione giornalistica vociante e petulante. Inutile? Inattuale? Può darsi. La lezione vanamente impartita da Fenice all’eroe Achille, preda della sua Hybris e accecato da Ate, nel pieno svolgimento di un sanguinoso conflitto produce echi che giungono fino a noi, lasciandoci ancora una volta senza risposte di fronte all’attualissimo aforisma krausiano: “I bambini giocano a fare i soldati. Ciò è comprensibile. Ma perché i soldati giocano a fare i bambini?”. ------- Infatti le preghiere [Litai] sono figlie del grande Zeus Zoppe, rugose e dagli occhi storti, Che si affannano a correre dietro ad Ate Ma Ate è forte e veloce nei piedi, per cui tutte Le lascia indietro di molto e si aggira per tutta la terra Colpendo gli uomini; e quelle la seguono e guariscono. Chi rispetta le figlie di Zeus che gli giungono accanto Ne avrà grande vantaggio e se le prega lo ascolteranno; Chi però le rinnega e le rifiuta con ostinazione Allora vanno a supplicare Zeus Cronide Perché Ate lo insegua e lo punisca con suo danno. Omero, (Iliade IX. 502 e ss.) A parlare qui è Fenice, il precettore di Achille, che tenta di convincere il giovane eroe a placare la sua ira, comprensibile come risposta al sopruso di Agamennone, per evitare che il suo giusto sdegno diventi arroganza e accecamento (Ate). Fenice con il suo discorso (l’unica prosopopea dell’Iliade) vuole illustrare come sia doveroso recedere dalle proprie posizioni, qualora i motivi per farlo siano a vantaggio del bene comune, se gli stessi dei, ben più potenti degli uomini, si lasciano piegare dalle suppliche. Come è noto, il suo intervento si rivelerà vano. Del resto, il motore dell’intero poema iliadico è proprio la Menis, l’ira. Incapace di prestare ascolto alle richieste dei compagni, di flettere dinnanzi alla nuova situazione e di elaborare la sua ferita narcisistica, Achille rivela qui la sua infantile intransigenza nel continuare a ignorare le pene e i lutti che travagliano l'armata greca, che soffre delle colpe di uno solo, l’anax andron Agamennone, al quale Achille rinfaccia la stessa hybris di cui egli qui pare essere vittima. Achille-bambino sembra manifestare un delirio di onnipotenza, mentre Fenice-adulto esprime la necessità di moderare le proprie ragioni in relazione a quelle della comunità di appartenenza. Il dissidio tuttavia si presenta impari, perché nel cuore dell’uomo l’elemento irrazionale è più forte ed è anche “più bello”, in quanto punta al soddisfacimento immediato delle pulsioni, all’affermazione del singolo che non tollera limitazioni, né ferite al suo “ego”. Partendo da questo passo, Werner Jaeger ci restituisce “l’immaginoso pensiero religioso dell’età arcaica, immune ancora dall’astrazione, che ravvisa nella commovente raffigurazione dei due demoni – Ate e Litai - e della loro impari gara per il possesso del cuore umano, l’intimo conflitto tra la passione cieca e il ravvedimento, il vero problema centrale di ogni educazione nel senso più profondo della parola. Il concetto moderno del libero arbitrio viene qui messo del tutto da parte, al pari dell’idea di colpa nel medesimo senso. Il pensiero antico è ancora molto più largo e perciò più tragico.”[1]. Corroborando quanto dice Jaeger nel passo sopra citato (“l’immaginoso pensiero greco è immune ancora dall’astrazione”), si può sicuramente dire che anche la lingua omerica è “immune dall’astrazione”, esprimendo la multiforme realtà del mondo e dei fenomeni con un vocabolario ricchissimo di quelli che la nostra lingua ben più sintetica e “povera”, usa definire “sinonimi”. In Omero, non va mai dimenticato, la varietà lessicale non è mera coloritura letteraria, espediente stilistico, ma espressione di realtà concretamente differenti l’una dall’altra[2]. Dovendo tradurre Omero nella nostra lingua, ci accade così di usare il verbo “pregare” in modo esteso, alternandolo con “supplicare”, implorare”, “scongiurare”, talvolta per mera scelta formale, ovvero per evitare le da noi sempre esecrate ripetizioni e senza avere consapevolezza delle distinzioni e delle peculiarità dei tanti modi con cui si prega e si può pregare[3]. Le preghiere qui personificate, le Litai, fanno riferimento al verbo lissomai, usato, ad esempio, da Saffo per pregare Afrodite dal trono variopinto[4], affinché faccia recedere l’amata e la faccia tornare da lei. La richiesta di una ricomposizione di un rapporto lacerato. Émile Benveniste ha analizzato i termini litai e lissomai, mettendoli a confronto con il latino litare (“ottenere un presagio favorevole”). Riferendosi anche a questo passo dell’Iliade, egli ne deduce che il senso della preghiera in questo caso si trova nell’idea di «faire agréer au dieu l’offrande de réparation»[5]. Dunque una preghiera riparatoria che, secondo Danièle Aubriot è “fondée en droit”[6]. Ate e Litai sono figlie di Zeus. La prima, pur essendo la maggiore, è paradossalmente più giovane e vigorosa[7], mentre le Litai arrancano faticosamente sul terreno, appesantite dagli anni e da una vista confusa. Esse sono dette “demoni” da Jaeger, nel senso dei daimones, originariamente esseri intermediari tra dei e uomini, che possono ostacolare i rapporti tra Cielo e Terra, ma che possono anche espletare un’azione di conciliazione tra le due dimensioni, così come fanno Ate e Litai, l’una distruttiva, le altre ricompositive. In un ulteriore passo dell’Iliade (XIX, 9 e ss.), Ate ha i piedi “apaloi”, cioè “delicati”, che la fanno avanzare non sul suolo, ma, fulminea, “sulle” teste degli uomini[8]; le Litai invece camminano incessantemente “tra” gli uomini, calcando il terreno e sembrano non avere requie nel loro continuo andirivieni tra Cielo e Terra. Questa sorta di “moto perpetuo” tra gli uomini e Zeus, nello sforzo costante di ricucire, ricomporre, ritessere relazioni interrotte, richiama ciò che fa la spola nel telaio, con il suo passare attraverso gli spazi aperti nell’ordito dai licci. Del resto il “liccio”, lys in greco[9], sembra avere la stessa radice di lissomai e individua proprio l’azione di “apertura di varchi”, che consente di (ri)costituire la trama a partire da fili distinti e quindi di creare la compattezza del tessuto delle relazioni tra uomini e tra uomini e divinità, “lacerato” da Ate. Non siamo distanti da una sensibilità che ritroveremo molto più tardi, nel Vangelo di Matteo 6, 14-15, ad esempio, laddove Cristo dice “Se voi infatti perdonerete (aphête) agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe[10].” In Omero però il perdono è sussunto dal “rispetto” per le figlie di Zeus, ovvero in una chiave più marcatamente giuridica. L’aspetto che qui maggiormente colpisce è tuttavia costituito dalle caratteristiche fisiche che nella prosopopea assumono le preghiere: esse sono “zoppe, rugose, dagli occhi storti”. Infatti, se ci si chiedesse oggi di dare un volto alle preghiere non le ritrarremmo certo così brutte e deformi, ma piuttosto come pie fanciulle con le mani giunte, soffuse di gentilezza e di eterea beltà. Certo, in un orizzonte dominato dalla kalokagathia, in cui il bello esteriore riflette quello interiore, non dovrebbe fare specie il fatto che le preghiere (Litai), comunque un segno di debolezza, un’ammissione di impotenza, siano rappresentate con un fisico debole e marcato dagli anni. A giustificare tale aspetto si è anche detto che esse finiscono per assumere le stesse caratteristiche fisiche del penitente: zoppe perché chiedere perdono è un’azione lenta e difficile, rugose perché i loro volti riflettono il conflitto interiore, strabiche perché non osano guardare in faccia colui al quale hanno arrecato danno. Suggestiva tuttavia e più convincente appare un’altra interpretazione della “deformità” delle Litai, secondo la quale non di manchevolezze si tratterebbe, ma all’opposto di facoltà accresciute [11]. Le Litai sono dunque χωλαί τε ρυσαί τε παραβλώπές τ' όφθαλμώ. Partendo dalla fine, le Litai sembrano avere un grave difetto della vista, che colpisce entrambi gli occhi (vedi il duale όφθαλμώ). Il verbo di base è βλέπω, che in Omero ha il significato di “puntare lo sguardo verso qualcosa”; la preposizione παρα- richiama il significato di “parallelo” e quindi, lungi dal significare una distorsione della vista (come lo strabismo, dal greco strepho, “volgere”, “distogliere”, che viene attribuito alle Litai in diverse traduzioni), rafforzerebbe la capacità di vedere acquisendo una duplice prospettiva simmetrica, in grado di conciliare visioni opposte. Le Litai sono anche χωλαί, “zoppe”, caratteristica all’apparenza difficile da riscattare in chiave positiva. Tuttavia gli studi di Marcel Détienne e Jean-Paul Vernant[12] hanno dimostrato che la zoppia nella Grecia antica non va vista solo come un difetto, ma al contrario di un rafforzamento delle capacità di orientarsi, di ponderare, sull’esempio di Efesto, il dio zoppo tra le cui virtù c’è sicuramente la Metis, la ponderazione, l’intelligenza pratica. Del resto Ate, come abbiamo visto, avanza “fulminea”, e dunque anche sconsiderata, “sulle” teste degli uomini. Infine sono dette ρυσαί, “rugose”. Paradossalmente, pur essendo più giovani di Ate, che vigoreggia in tutta la sua impulsività distruttrice, possiedono un tratto caratteristico della vecchiaia, cioè a dire, anche in questo caso, quello della ponderazione necessaria a giudicare e a valutare in base all’esperienza e alla riflessione, qualità tipiche degli anziani, tenute in gran conto nel mondo omerico[13]. Ed ecco che sotto questa luce il verbo lissomai, lungi dall’avere un significato di debolezza e di resa, indicherebbe un pregare che, facendo perno su una superiore capacità di comprendere le relazioni tra gli uomini, raggiunta dopo un processo di maturazione e di rielaborazione dell’errore, è volto alla ricomposizione. In buona sostanza le Litai, nella loro incessante azione di ricucitura tra cielo e terra o, se si vuole, tra irrazionale e razionale, ben sintetizzerebbero i due pilastri delfici del Meden agan e del Gnothi seauton nell’esortare l’uomo a non eccedere, ad accettare l’errore e il nostro comune destino di fallibilità.
[1] Werner JAEGER, Paideia, I pp. 72-73. Interessante altresì il fatto che Jaeger parli di “due demoni”, laddove Ate, “accecamento” è singolare, mentre le Litai sono plurali, quasi che la follia sia unica e i modi di ravvedersene molti. [2] Bruno SNELL, La cultura greca e le origini del pensiero europeo, Torino, 1963, p. 18 e ss. [3]Sulla preghiera in Omero, cf A. CORLU, Recherches sur les mots relatifs à l'idée de prière, d'Homère aux Tragiques, Paris, Klincksieck, 1966. Quanto al verbo lissomai, l’A. lo considera essenzialmente poetico (tre sole occorrenze nella prosa di Erodoto) ed esprime, almeno in origine una preghiera rivolta “a pari”, siano essi uomini o dei. Solo più tardi le Litai sono implorazioni rivolte da uomini agli dei. [4] Saffo, Diehl 1, 2. Laddove, ad esempio, la Poetessa in Diehl 36 usa kelomai per pregare Gongila di venire da lei, nel senso di “esortare”, “implorare”, “chiedere ad alta voce”. [5] Le Vocabulaire des Institutions indo-européennes, Paris, 1969, t. II, p. 245-255. [6] Danièle AUBRIOT, Les Litai d’Homère et la Dìke d’Hésiode, in «Revue des Études Grecques », t. 97, fasc. 460-61, Janvier – Juin, 1984, pp. 1-25. Qui p. 4. In tal senso, la stessa Autrice ipotizza un confronto tra Litai omeriche e la Dike esiodea. [7] Cf. Il, cit.: “Ma Ate è forte e veloce nei piedi, per cui tutte le lascia indietro di molto e si aggira per tutta la terra colpendo gli uomini”. [8] Aldo LO SCHIAVO, Omero filosofo, Firenze 1983, p. 100. [9] Per Esichio equivale al latino “Obliquus”, “sghembo”, “che sta a traverso” rispetto ai fili del tessuto. [10] Qui il verbo è aphiemi, “mandar via” scacciare”, “deporre”. [11] Danièle AUBRIOT, op.cit., pp. 18 e ss. [12] Le astuzie dell’intelligenza nell’antica Grecia, Roma-Bari, 1999. [13] Basti pensare agli altri «grandi vecchi» del poema oltre a Fenice, Crise, Nestore, Priamo, che non esitano a implorare il proprio interlocutore, dando prova di saggezza e di moderazione, per il bene della comunità. Anche Crise lisseto pantas Achaious (I, 11, 370), ma, ottenuta la restituzione della figlia, usa il verbo euchomai per pregare Apollo di far cessare la pestilenza. Come Fenice, lo stesso Priamo, in un’altra, drammatica visita alla tenda di Achille nella parte finale del poema, prega Achille perché gli restituisca il corpo di Ettore usando lissomai (XXIV, 485). |